Mitologia giuridica del Patrimonio Culturale: cosa si intende e quali sono gli aspetti principali?
La giurisprudenza in materia di Patrimonio Culturale è attraversata, da decenni, da diverse tendenze principali che assumono, simbolicamente, le sfumature di Miti Giuridici. Si tratta di elementi che si inseriscono nel disegno di regolazione giuridica del settore, la cui disciplina si delinea, in Italia e all’estero, a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso.
Regolazione giuridica
Pilastri di una diffusa ed effettiva consapevolezza della categoria dei beni culturali da parte della scienza giuridica sono le Convenzioni UNESCO del 1970 e del 1972, dalle quali deriva un articolato sistema di istituzioni, norme e procedure ultrastatali.
La Convenzione UNESCO del 1970 rappresenta, nello specifico, il primo documento internazionale rivolto a contrastare il traffico illecito di beni culturali, ad oggi sottoscritto da 132 stati.
Con la Convenzione UNESCO del 1972 si stabiliscono i presupposti volti ad incoraggiare i Paesi membri a identificare e tutelare il proprio patrimonio che sia o meno iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.
In Italia la disciplina in materia di patrimonio Culturale assume dignità giuridica con l’istituzione, nel 1974, del MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, voluta dal Ministro Spadolini, seguita dal riconoscimento costituzionale delle funzioni di tutela e valorizzazione.
Mitologia giuridica
Nel disegno della regolazione del patrimonio culturale si inseriscono diverse tendenze su cui è necessario porre l’attenzione.
Si tratta di elementi che assumono le sfumature di miti giuridici, esprimendo regolarità, aspetti o conseguenze della politica e/o di personalità politiche.
Scopriamo insieme quali sono i miti giuridici inerenti il patrimonio culturale.
1. BENCUTURALISMO
Riassume la tendenza a considerare il concetto di patrimonio culturale come un raccoglitore di categorie eterogenee di cose e beni.
La prima apparizione del concetto risale al 1949 ne La tutela delle cose d’arte, in cui l’autore Mario Grisolia fornisce una definizione del concetto di Bene Culturale, specificando quali beni risultino compresi nella categoria osservata.
La nascita della locuzione come gruppo, insieme, di cose, ha determinato una generale disattenzione giuridica verso soggetti e istituzioni del settore Culturale, ad eccessivo favore dell’oggetto regolato. Un esempio è fornito dagli archivi e dalle biblioteche, la cui rilevanza giuridica si sostanzia in misura decisamente esigua.
2. VALORIZZAZIONE
Il secondo mito giuridico riguarda la definizione delle funzioni in materia di beni e attività Culturali, e il suo lungo e complicato sviluppo.
Tracciamo una linea storica ed evolutiva del concetto di valorizzazione:
- 1918 ➛ Marcel Proust, scrittore, saggista e critico letterario, include l’arte del valorizzare tra le arti del nulla
- 1964 ➛ La nozione valorizzazione, in Italia, è utilizzata per designare attività volte a perseguire La fruizione, la promozione e la conoscenza del patrimonio culturale
- 1998 ➛ Il concetto di valorizzazione acquisisce piena dignità giuridica
- 2001 ➛ E’ inserito, al pari della tutela, nell’art. 117 Cost.
- 2004 ➛ la nozione di valorizzazione subisce un ridimensionamento dal Codice dei Beni culturale e del paesaggio, il quale sottrae la funzione di fruizione alla valorizzazione per unirla alla tutela
- 2009 ➛ Nasce una struttura dedicata alla funzione della valorizzazione
- 2014 ➛ Struttura (di cui sopra) soppressa. I compiti assegnati alla struttura sono distribuiti tra gli uffici del Ministero, a livello centrale e periferico.
3. RIORGANIZZAZIONE
Istituito nel 1974, il Ministero per i beni culturali e ambientali ha subito sei riorganizzazioni.
Riformato nel 1998, È stato oggetto di riordino nel 2004, nel 2007, nel 2009, e ancora nel 2021.
Si tratta di uno sciame normativo che non è stato in grado, fino ad ora, di fornire adeguate risposte alle esigenze del Ministero, quali ad esempio, eccessive giacenze finanziarie e scarso coordinamento tra uffici centrali e periferici.
Indicativo in tal senso è il sottodimensionamento dell’organico, cui i numerosi riordini non sono stati in grado di rispondere con efficienza ad un’esigenza tanto evidente quanto allarmante.
In conclusione, la regolazione di un settore in cui materialità e immaterialità convivono, dialogando tra loro e determinandosi vicendevolmente, è impresa assai ardua.
Con la recente riorganizzazione del Ministero, che ha perso gli appellativi Beni e Attività a favore di una più generica specifica Cultura, è possibile che la situazione cambi.
La domanda è: in positivo o in negativo?


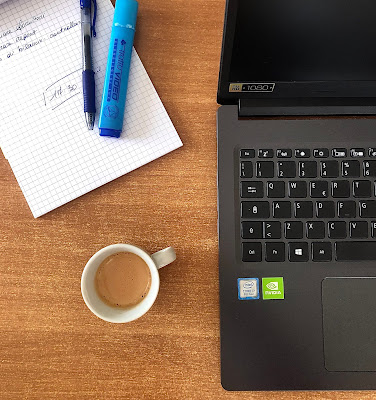
Commenti
Posta un commento