Il ruolo delle Istituzioni nel settore Culturale e Creativo
Fonte: ilmeridio.it
Quali meccanismi regolano il settore Culturale e Creativo?
Quale ruolo, le Istituzioni, rivestono all’interno di questo scenario?
Scopriamolo insieme, partendo dalla definizione dell’attuale modello di governance del sistema culturale italiano in modo da comprendere con maggiore chiarezza gli interventi legislativi in ambito Culturale attuati dallo Stato.
Per governance si intende il “sistema di meccanismi, regole e modalità di loro applicazione, nonché politiche tramite cui si determinano gli individui e le istituzioni partecipanti, se ne definiscono contributi e ricompense e se ne compongono gli interessi in fini comuni, orientandoli / incentivandoli in tal senso”.
L’attuale modello di governance del sistema culturale italiano è basato principalmente sulla centralità dello Stato. Si tratta di un modello che identifica lo Stato con la Repubblica, forzando l’interpretazione dell’Articolo 9 della nostra Costituzione, secondo cui:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
Focus sul modello: sintesi e criticità
Il modello risulta focalizzato sulle strutture ministeriali statali, ignorando quelle periferiche dell’articolo 144 Costituzionale:
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”,
E non riconoscendo loro la funzione di valorizzazione e di gestione.
Grave disattenzione, se si pensa che è a partire da questa criticità che il rapporto tra patrimonio culturale e comunità si è indebolito, arrivando ad esprimersi in forme di estraneità e di disinteresse.
Atteggiamento che si è rafforzato nella stagione segnata da scelte riformatrici, dalla Legge quadro del ’98 a quelle più recenti del ministro Franceschini, criticate di ridimensionare le funzioni dello Stato a favore dei Comuni per apportare vantaggi a ipotetici speculatori, nell’ottica di una mercificazione del Patrimonio Culturale.
Qualcosa sta cambiando: scopriamo insieme i motivi e i nuovo approcci
Negli ultimi anni si sta assistendo ad un cambiamento di approccio, da parte delle istituzioni, nel settore culturale. Cambiamento che trova la sua origine al livello delle regioni e degli enti locali, più vicini e quindi più sensibili ai bisogni e alle necessità dei cittadini.
Come scrive Ledo Prato, esperto nelle politiche per i beni Culturali: “Il metro di misura delle nuove politiche pubbliche per la cultura va ritrovata alla scala urbana, in una concezione che colloca le politiche per il patrimonio all’interno dei contesti e quindi delle politiche di rigenerazione urbana, della riorganizzazione delle periferie, della democrazia partecipativa, contribuendo alla costruzione di un nuovo welfare community”.
Per risanare il rapporto tra comunità e patrimonio culturale, indebolito da manovre errate e poco orientate al benessere della comunità, è necessario che le istituzioni coinvolgano la comunità e l’impegno dei cittadini associati favorendo quella condizione di coesione sociale capace di creare i presupposti per un dialogo efficiente tra produzione e consumo, tra gestione ed utenza.
Dialogo che vede nella cultura il suo promotore sociale ed economico.
Le organizzazioni che operano nel culturale, nelle diverse vesti giuridiche di Fondazioni, associazioni, cooperative, coniugano il valore scientifico e culturale con importanti risvolti socio economici, in termini di occupazione, di creazione di forme di economia, di lotta all’illegalità (sicurezza e recupero di soggetti a rischio).
Ed è proprio a partire da queste esternalità e da esperienze di partecipazione attiva dei cittadini che il dibattito culturale si apre a nuove modalità di intervento da parte delle istituzioni.
Nuove modalità di intervento istituzionale
Un esempio del rinnovato interesse delle istituzioni è l’Art Bonus: Legge 83/2014 che ha istituito un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato per i mecenati, cioè per coloro che finanziano la cultura nel nostro Paese. Il beneficio è rivolto a chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, ed è stato stabilizzato e reso permanente dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015). Gli interventi finanziati, nello specifico, sono:
Altro esempio di politica di promozione della Cultura è il Piano MIBAC: Cultura Futuro Urbano, che in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2013 e quelli dell’Agenda Urbana Europea, prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro fino al 2021 con l’obiettivo di incrementare, innovare, migliorare servizi e funzioni culturali nelle scuole e nelle biblioteche delle periferie, anche recuperando opere rimaste incompiute. Il piano prevede il finanziamento di oltre 100 progetti ed è articolato in tre sezioni principali:
1. Scuola attiva la cultura
2. Biblioteca casa di quartiere
3. Completati per la cultura
Sono tentativi che provano a cambiare il baricentro ordinario: ci riusciranno?
Ce ne saranno altri?
Riflettiamoci insieme.


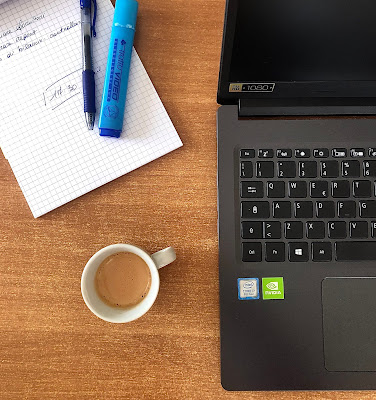
Commenti
Posta un commento