Convenzione di Faro: dal patrimonio all'eredità culturale
Scopriamo perché!
Il principale carattere di innovazione dell’atto consiste nel passaggio dalla nozione di “patrimonio culturale” a quella più inclusiva di “eredità culturale”. All’art. 2 della Convenzione se ne dà una definizione:
l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi […].
Ciò che risulta immediatamente chiaro, è il carattere intergenerazionale dell’eredità culturale: è un insieme di risorse ereditate da generazioni precedenti, che deve essere tramandato alle generazioni successive nelle migliori condizioni possibili.
L'idea di intergenerazionalità, a dirla tutta, è insita anche nella nozione di "patrimonio": esso deriva infatti dal latino patris munus, "il dono del padre", a chiarire il passaggio di testimone da una generazione all'altra. La nozione di "eredità" rafforza questa linea e la libera da qualsiasi incomprensione, rendendola immediata e di facile comprensione.
Ma a chi spetta l'oneroso compito di proteggere e trasmettere l'eredità culturale?
La Convenzione è ancora una volta molto chiara a riguardo: esiste una responsabilità sia collettiva sia individuale nella salvaguardia dell’eredità. Ciò si esplica nella nozione di “comunità di eredità”: insieme di persone che si riconosce in determinati aspetti dell’eredità culturale e che è intenzionata a proteggerli e tramandarli (art.2 comma 2). Quello all’eredità culturale si configura, dunque, come un diritto del cittadino a parteciparvi senza impedimenti, ma comporta al contempo il dovere non solo di proteggere l’eredità culturale della propria comunità, ma anche di rispettare quella altrui. In questo quadro, è l’Europa stessa ad essere concepita come una “comunità di eredità”, con dei propri valori, una propria memoria storica e costituita, altresì, da diverse eredità culturali.
I Paesi aderenti, si impegnano, tra le altre cose:
-Ad avviare processi di identificazione, di studio e dunque di conservazione dell’eredità culturale, al fine di metterne il luce il valore
-A diffondere la conoscenza della stessa, per sensibilizzare la collettività all'attività di salvaguardia
-Ad attuare politiche sociali per garantire la piena accessibilità di tutti alla partecipazione all'eredità culturale
L’eredità culturale non rimane come una bella idea platonica, confinata a una dimensione puramente metafisica, ma viene intesa esplicitamente come una risorsa per lo sviluppo economico sostenibile delle comunità, a patto che ciò non ne comprometta l’integrità e i valori fondanti. Si auspica, inoltre, la gestione integrata dell’eredità culturale che coinvolga attori diversi: istituzioni pubbliche ma anche privati, imprese, esperti, società civile. Si apre, dunque, al riconoscimento di forme di gestione inedite, talvolta presenti di fatto nei contesti territoriali, ma difficilmente inquadrabili in ambito giuridico.
Ad oggi, i paesi firmatari sono 25; di questi, solo 20 l’hanno ratificata.
L’Italia ha firmato la Convenzione nel 2013 e l’ha ratificata solo recentemente, nel dicembre 2020; la data per l’entrata in vigore è stimata per l’Aprile 2021, stando alle fonti ufficiali.*
Ricordiamo che la Convenzione è un atto di diritto internazionale e non comunitario come saremmo erroneamente indotti a pensare: il Consiglio d'Europa, infatti, non è un organo dell'Unione Europea! In quanto tale non stabilisce obblighi, né detta azioni da compiere ai paesi: essi sono infatti liberi di agire internamente in quanto sovrani. La Convenzione detta delle linee guida e apre delle possibilità di azione, che ciascuno Stato declina secondo il proprio ordinamento interno.
In conclusione, la Convenzione di Faro sancisce il diritto all'eredità culturale come diritto fondamentale dell'uomo e apre a nuove forme di gestione, finora di difficile inquadramento. Rimette al centro della relazione i veri custodi della cultura: le comunità.
*(fonte:https://www.coe.int/it/web/conventions/fulllist//conventions/treaty/199/signatures?p_auth=gJCljkKO)


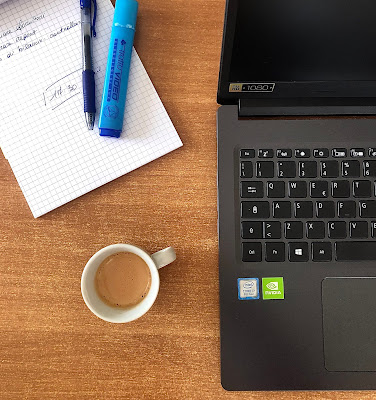

Commenti
Posta un commento