Rigenerazione urbana a base Culturale: cornici istituzionali a confronto
 |
In questo contesto risulta fondamentale il ruolo della Cultura.
Rigenerare tessuti urbani attraverso interventi sociali e culturali significa dare alle comunità spazi e strumenti in cui esprimersi e confrontarsi, arricchendone, tra l’altro, il capitale sociale ed economico.
Il settore culturale, di fatti, ricopre una posizione di primo piano nella crescita sociale individuale e collettiva. Le organizzazioni culturali, nelle diverse vesti giuridiche di fondazioni, associazioni, cooperative, società di grandi e piccole dimensioni, rappresentano veri e propri luoghi di cittadinanza e interculturalità in cui creare e ricreare relazioni, progetti, passioni. Presupposti, questi, che offrono ai cittadini importanti chance di futuro e solide condizioni di sviluppo.
Rigenerare tessuti urbani attraverso interventi sociali e culturali significa dare alle comunità spazi e strumenti in cui esprimersi e confrontarsi, arricchendone, tra l’altro, il capitale sociale ed economico.
Uno sguardo più attento rivela un forte legame tra organizzazioni culturali e territori in cui queste abitano e si esprimono. In particolare, è a partire dal livello locale, quindi amministrazioni pubbliche, enti non profit, associazionismo, comunità, che nascono le condizioni adatte per la costruzione di un contesto adatto alla programmazione e allo sviluppo di politiche culturali in grado di affrontare emergenze in primis sociali, mentre i governi nazionali, con alcune eccezioni, si limitano in larga parte alle dichiarazioni di principio.
A questo proposito, “il panorama europeo è caratterizzato da una chiara discriminante geografica fra il Nord e il Sud: da un lato si trovano l’Italia e la Spagna, che, ancora assorbite dallo sforzo di tutelare il patrimonio ereditato dal passato e nello stesso tempo ancora traumatizzate dal loro brusco passaggio da Paesi di emigrazione a principali magneti europei dell’immigrazione, stentano ad aprirsi a queste nuove tematiche, dall’altro lato figurano i Paesi nordeuropei di antica immigrazione come l’Olanda e la non più europea Gran Bretagna, e i Paesi scandinavi, che hanno invece meglio inteso le potenzialità inclusive della cultura e spingono maggiormente in questa direzione”.
Emblematico in questo senso è il caso dell’Arts Council of England, che nel corso degli anni Novanta, da agenzia culturale votata al mecenatismo degli artisti e delle arti è divenuto agente di cambiamento sociale attraverso la cultura. Due dei suoi nuovi uffici – la Social Inclusion Unit e la Cultural Diversity Unit – sono infatti particolarmente attivi nel promuovere, l’uno, processi di riabilitazione e risocializzazione tramite la cultura in alcuni settori specifici (carceri, ospedali…), e più in generale nell’ambito del disagio sociale; l’altro, la comprensione e il dialogo interculturale attraverso il sostegno alla diversità della produzione artistica e dei “nuovi pubblici”.
Va precisato, ad ogni modo, che in Italia “la ricca articolazione delle esperienze avviate al livello decentrato in questi nuovi territori dove il culturale e il sociale tendono a ricongiungersi, stenta ancora a riflettersi e a comporsi in un disegno d’insieme al livello del sistema paese”.
In assenza di generali azioni di impulso e di analisi e mappatura, i diversi laboratori avviati con successo rischiano di restare episodi isolati se non tutelati e sostenuti dall’amministrazione statale della Cultura.
Best practice: Gran Bretagna
La Gran Bretagna è stata tra i primi Paesi ad intuire il ruolo determinante della cultura nel dibattito sociale ed economico. Ha di fatti sviluppato politiche integrate in risposta ai fenomeni sociali, attenzione che ha coinvolto l’apparato statale trasformandone in maniera profonda anche la struttura organizzativa.Emblematico in questo senso è il caso dell’Arts Council of England, che nel corso degli anni Novanta, da agenzia culturale votata al mecenatismo degli artisti e delle arti è divenuto agente di cambiamento sociale attraverso la cultura. Due dei suoi nuovi uffici – la Social Inclusion Unit e la Cultural Diversity Unit – sono infatti particolarmente attivi nel promuovere, l’uno, processi di riabilitazione e risocializzazione tramite la cultura in alcuni settori specifici (carceri, ospedali…), e più in generale nell’ambito del disagio sociale; l’altro, la comprensione e il dialogo interculturale attraverso il sostegno alla diversità della produzione artistica e dei “nuovi pubblici”.
Italia
In Italia, a differenza della Gran Bretagna, manca una cornice nazionale sotto il profilo istituzionale e programmatico relativa a questo dibattito. Di fatti, gli interventi più articolati e innovativi in campo culturale sono in larga parte intrapresi al livello locale, dove i programmi e le attività, realizzate negli ambiti della riqualificazione urbana, sono più vicini ai cittadini e quindi più sensibili ai bisogni della comunità.Va precisato, ad ogni modo, che in Italia “la ricca articolazione delle esperienze avviate al livello decentrato in questi nuovi territori dove il culturale e il sociale tendono a ricongiungersi, stenta ancora a riflettersi e a comporsi in un disegno d’insieme al livello del sistema paese”.
In assenza di generali azioni di impulso e di analisi e mappatura, i diversi laboratori avviati con successo rischiano di restare episodi isolati se non tutelati e sostenuti dall’amministrazione statale della Cultura.
Una possibile soluzione a queste assenze può essere rappresentata dalla creazione di strategie di reale cambiamento ed innovazione, quali, ad esempio:
- Definizione di nuovi criteri nell’erogazione dei finanziamenti pubblici alla cultura e ai soggetti che vi partecipano, come ad esempio agevolazioni fiscali per i mecenati;
- Uso di strumenti legislativi e regolamentari che favoriscano un uso più attento e partecipativo dei media;
- Creazione di una rete nazionale costituita dai professionisti del settore, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto in un clima di ispirazione generale (ipotesi diversa dalla creazione di un albo dei professionisti del settore, di cui è avvertita la forte, fortissima, necessità allo stesso modo).
In foto: Bosoletti, ResisTiamo. Napoli, Rione Sanità.

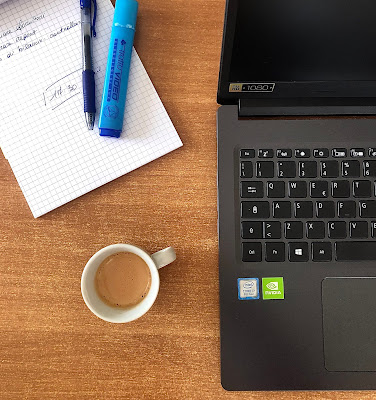

Commenti
Posta un commento